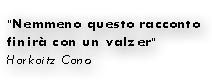
Nemmeno questo racconto finirà con un valzer
Non diamo ai gesti l'importanza che hanno. Un grave errore, perché a volte tutto quello che abbiamo non è altro che un gesto. Può non restarci nemmeno uno spicciolo, né una parola, solo un gesto.
Perché se ti dicessi che lei non ha lasciato in te nessuna frase memorabile, né il ricordo di una passeggiata - non priva di pretese borghesi - fatta un giorno lungo un fiume le cui acque brillavano come una trota messa a seccare al sole, bensì un gesto discreto? Che il suo ricordo non suscita in te né risa né pianto, e nemmeno comportamenti lodevoli o biasimabili e che, in fondo, l'unica impronta che lei ha lasciato in te è proprio un gesto?
Ancora oggi, anche se sono passati molti anni da quegli avvenimenti, senza saperlo tu compi un gesto che imparasti da lei. Un gesto che, per la simpatia che ti ispirava, per sentirti più vicino e unito a lei, iniziasti inconsapevolmente ad imitare e che altrettanto inconsapevolmente continui a ripetere. Un semplice gesto che, senza saperlo, perpetui nel tempo. Un gesto che lei ti contagiò e che poi, attraverso il tuo corpo, altre ragazze avrebbero appreso. Fino al giorno in cui il mondo smetterà di essere mondo.
Forse non sei altro che questo: il filo conduttore che catalizza il gesto di una persona scomparsa, il sottile condotto dell'alambicco che distilla l'essenza dei gesti da un'ampolla all'altra.
Non sto parlando di un gesto eroico, o di uno di quelli che cambiano il corso della storia; non sto pensando al pollice verso l'alto o verso il basso degli imperatori romani.
Ma una cosa è certa: non diamo ai gesti l'importanza che hanno. Non capiamo la trascendenza del rosicchiarsi le unghie per colui al quale stiamo facendo passare un brutto momento, non percepiamo le reali dimensioni della speranza distrutta nello sguardo a terra della ragazzina a cui abbiamo dato un dispiacere.
Non solo il deambulare barcollante dell'ubriaco che da sotto un lampione sparisce nel nulla è segno di una probabile caduta, non solo il pavoneggiarsi della vecchia e nobile matrona che muove il suo ventaglio di carta, il mento all'insu, rivela il disprezzo per il servitore che conosce il codice di questo abbecedario gestuale comune a sudditi e tiranni; non solo il sorriso della madre mentre offre la mano e il grembo al figlioletto che ha appena mosso i primi passi; non si tratta solo del gesto furioso dell'oste che batte il pugno sul bancone di legno e fa vibrare la bottiglia, le sue corde vocali e perfino le stesse fondamenta della taverna. Portiamo a questa canzone e a queste righe il gesto di alleviare con la mano i dolori alle costole lasciatici dal letto dove dormivamo da bambini, il movimento leggero e ballerino rimasto nelle nostre spalle dal momento in cui cercammo di attirare in modo ridicolo l'attenzione della ragazza che ci piaceva. Questo racconto, per servire a qualcosa, dovrebbe portare con sé una danza, un valzer, una partitura da ballare in parchi ampi e deserti. Ricordamelo, per favore, se prima di averlo terminato non avrò ancora aggiunto un ballo a queste righe.
Perché questa non è altro che la storia di un gesto. Un gesto scelto, se si vuole, appreso, incosciente, involontario, desiderato; la storia di un gesto che nega uno a uno qualsiasi aggettivo gli venga posto accanto.
La strada profumava di cannella. Non di cannella in polvere, ma di cannella in bastoncini. E' diverso.
Molto diverso.
La cannella in polvere porta con sé il dolce invito a fermarsi in un luogo, la possibilità che il vento disperda quella polvere e il rischio che si infili nelle narici. La cannella in polvere trae reminiscenze di sabbie sottili, di altre polveri che riportano alla mente teli leggeri che sulla superficie dei deserti si sollevano e si muovono come veli. Non succede la stessa cosa con il profumo della cannella in bastoncini.
La cannella in bastoncini riporta alla mente la tensione, i ponti, i muscoli tesi pronti per lo sforzo, il bambino che tutte le domeniche raccoglie rametti secchi per l'inverno, le questioni non ancora risolte e per questo non ancora rovinate. Elementi in tensione, forse troppo secchi e rigidi, ma nonostante ciò, vivi.
Forse sarà stata la presenza di quella drogheria che emanava essenze e aromi portati dalla Turchia, ma in via Chocimska c'era profumo di cannella. Dovrei iniziare così, se finalmente in qualche modo iniziassi, una volta deciso che val la pena raccontare questa storia.
In via Chocimska, ad un angolo c'era sempre un ragazzo che vendeva il quotidiano Kurier Warzawski; Minkiewicz aveva un negozio di cappelli, Kotkowski invece una panetteria, e più in là la drogheria turca e, oltrepassata quella, uno chiudeva gli occhi e non c'era modo di sapere che altri negozi o portoni ci fossero fino alla fine della strada. Io per lo meno mi limitavo a salutare i primi tre, compravo il giornale dal venditore del Kurier di cui non conoscevo il nome, salutavo da lontano il signor Minkiewicz - sempre con il gilè e il metro da sarto al collo - e chiedevo alla signora Kotkowski notizie delle sue birbanti figlie.
La prima volta che la vidi in quella via, aveva la stessa rigidità della cannella in bastoncini. Quando ci incrociammo, non riuscii a toglierle gli occhi di dosso. Camminava svelta, tenendosi il cappello con una mano. Non liberai il suo viso dalle briglie dei miei occhi. Tentai di acciuffare il suo sguardo, dai tesoro, dai, guarda da questa parte, fammi questo piccolo regalo e per oggi mi renderai felice. Le sue pupille scorsero l'esca e, invece di girarsi verso di me, ruotò la testa a destra rivolgendo casualmente i suoi occhi ai dolci della panetteria di Kotkowski. Scelse quel gesto. Ma ci mancò poco. Se non si fosse resa conto che l'esca era un'esca, sarebbe stata mia in quello stesso momento.
Da allora ci incontrammo spesso. Io la guardavo senza nascondere il mio interesse, senza fermarmi tracciavo con lo sguardo una traiettoria ellittica, girando la testa prima leggermente a sinistra, quando passava sul marciapiede, e poi sempre più a sinistra, finché non si trovava ormai dietro di me ed ero costretto a guardare di nuovo avanti, perché nemmeno con la coda dell'occhio potevo ormai vederla. Che peccato non poter ruotare la testa di trecentosessanta gradi! Così pensavo in quelle occasioni, sentendomi limitato dalla scarsa capacità dei miei occhi. E quando io giravo la testa a sinistra, lei, che scendeva, la girava a destra a volte verso la forneria di Kotkowski, altre alla cappelleria di Minkiewicz, altre ancora ad un'altra vetrina qualsiasi, come se fosse interessata alla sua immagine riflessa nel vetro e non alla mia, o come se davvero guardasse i dolci o i cappelli. Era quello che io volevo credere, povero me!
Quante volte si ripeté quel gioco delle teste che si giravano. A sinistra il mio sguardo che cerca lei mentre risalgo la via, a destra il suo, che procede in direzione contraria, schivando l'esca e trovando rifugio nelle vetrine sulla destra.
Dopo tre mesi mi avvicinai a lei, un giorno in cui le era toccata la vetrina dei cappelli.
Non ti sembra che i Minkiewicz facciano i loro cappelli con filo di cannella?
Il suo sguardo abboccò per la prima volta all'amo. Non fece nemmeno finta di non aver capito. Non fece nemmeno lo sforzo di dirmi che quella faccenda della cannella era dovuta alla drogheria turca. Mi regalò il suo sguardo, perfettamente avvolta nell'aroma della cannella in bastoncini.
Si chiamava Alma e lavorava all'Opera. Il suo compito era girare le pagine della partitura del pianista, in modo che lui non dovesse distogliere le mani dalla tastiera. Non mi rispose quando, provocatoriamente, le chiesi se quella fosse una professione. E ciò che veramente le parve ridicolo invece fu il mio di lavoro, cioè voler essere uno scrittore. Mi chiese se pensavo che per essere scrittore fosse sufficiente ubriacarsi nel cabaret Adria o prendere il caffè allo Zodiac. Fatto sta che da quel giorno iniziammo a passeggiare assieme sulle rive della Vistola e che il mio collo continuò a girarsi verso sinistra per poterla guardare - le piaceva passeggiare stando alla mia sinistra, era una specie di mania - e nonostante lei continuasse a girare la testa a destra, adesso non lo faceva più per guardare il negozio di cappelli di filo di cannella o i dolci stile Panama, ma per girarsi verso di me. Infatti io camminavo alla sua destra, al posto del negozio di cappelli o di quello di dolci, una specie di copricapo ambulante che riceveva i suoi baci quando raggiungevamo l'angolo meno illuminato della strada - so che non avrei mai dovuto mostrare tanta tenerezza, ma ero innamorato, che ci possiamo fare.
Probabilmente anche il suo gesto continuava ad essere lo stesso, ma adesso lo faceva per guardare me. Uno accanto all'altra, camminavamo entrambi nella stessa direzione.
Una domenica ci allontanammo da Varsavia, con l'idea di pranzare in campagna. Quando stendemmo la tovaglia sul prato, notammo qualcosa che si muoveva nell'erba umida, che strisciava sotto la tela: eravamo in un campo pieno di lumache.
Rimanemmo ad osservare il loro affascinante guscio a spirale. Poi lei strofinò le sue lunghe dita - dita da sfogliatrice di partiture, che fosse o no una professione - come se volesse schioccarle, se non fosse stato per la bava lasciata dalle lumache. Avvicinò le dita al naso, per annusare quella sostanza vischiosa. Fece un'espressione schifata e la mia inquietudine si fece ancora maggiore; sentivo i calzoni troppo stretti.
Il giorno dopo mi portò nella sala delle prove dell'Opera, sorprendendomi con un'improvvisa audacia che la rendeva ancora più attraente ai miei occhi. Un leggio di legno cadde a terra mentre ci stavamo spogliando. Quando infilò la mano nella tasca centrale dei miei calzoni, sentii il cervello accecarsi; non le sfuggì la mia respirazione affannata e notò una certa umidità sul polsino della camicia. Umida e calda anche la pelle del suo polso, poiché il vestito che indossava era così leggero che sembrava di carta. Poi mi sorrise, dolcemente.
Sei più veloce anche delle lumache.
Subito dopo avvicinò le dita al naso e odorò lo sperma con curiosità, mentre sorrideva e strofinava le dita come se volesse schioccarle, se non fossero state umide.
Solo un gesto, indimenticabile.
Pur non avendo abbandonato il sogno di diventare uno scrittore, iniziai a lavorare come impiegato negli uffici di una grande falegnameria.
Quando mostrai ad Alma il mio primo racconto, le sembrò troppo contorto e mi rimproverò di non averla mai portata a ballare. Aveva una capacità speciale di saltare da un argomento all'altro, di girare pagina in un attimo. Bisogna capire che quello era il suo lavoro: girare elegantemente le pagine degli spartiti.
Le dissi che saremmo andati a ballare a capodanno.
Mentre davo alle fiamme del camino di casa il mio primo racconto, confessai a me stesso di non saper ballare.
Quando il quaderno dei racconti e dei tentativi di racconto era ormai preda delle fiamme del camino, mia madre entrò in cucina.
Madre: Cosa stai bruciando?
Io, a me stesso: paglia. Ma dissi un'altra cosa:
Mi insegni a ballare, mamma?
Mia madre ci provò, ma i suoi sforzi servirono a ben poco: ballare nella cucina di casa e ballare nello Zodiac la notte di capodanno non erano esattamente la stessa cosa. Anzi, direi addirittura che erano due tipi di danza opposti.
Alma mi diceva che dovevamo muoverci di più, ma io non riuscivo a spostarmi più di quanto non facessi nella cucina di casa, benché nella gigantesca pista dello Zodiac ci fosse spazio in abbondanza. Ero uno di quei ballerini che si potrebbero definire da cucina, più che da sala da ballo.
Il direttore che avevamo in ufficio era un autentico idiota.
Aveva una stanza tutta per lui, ma lasciava sempre la sua giacca nel nell'ufficio di noi altri tre (il vecchio Slowacki, che si occupava della contabilità, il giovane Jozef che faceva commissioni di ogni tipo e che aveva la mia stessa età, ed io) dove aveva messo il suo attaccapanni. Nel suo ufficio c'era spazio in abbondanza per mettere un attaccapanni, ma invece no: l'aveva collocato nel nostro ufficio dove tutti i giorni appendeva la sua giacca. Come capii più tardi, quell'attaccapanni era come l'asta che si conficca su un terreno appena conquistato; la giacca, invece, la bandiera issata su quell'asta. In questo modo il capo poteva entrare in qualsiasi momento nel nostro ufficio, per controllare il nostro ritmo di lavoro o il nostro umore, e per verificare che stessimo facendo tutto quello che ci aveva detto di fare esattamente come ce l'aveva ordinato.
È dentro? Chiedeva il signor Slowacki, il quale, nonostante i suoi sessant'anni passati, aveva ancora paura della reazione del capo, quando arrivava, trafelato, in ritardo.
Era incredibile la paura che Slowacki aveva di lui. Era stato a fianco del generale Haller nel 1919, aveva combattuto contro i bolscevichi russi, ma di quell'uomo aveva paura. Era stato decorato in guerra, cosa che non gli aveva garantito comunque il rispetto di nessuno. Non gli aveva dato nemmeno il coraggio di mostrare al capo il suo valore. Essere capaci di sopravvivere in guerra non significa necessariamente essere in grado di saper sopravvivere anche fuori dalla guerra.
Ma stavo parlando dell'attaccapanni.
In ogni caso, non era affatto necessario che il direttore venisse nel nostro ufficio. La sua disgustosa giacca ci ricordava perennemente la sua presenza. L'attaccapanni era il simbolo del suo potere, un monito al lavoro veloce e preciso. Sebbene allora non lo sospettassi minimamente, nel giro di un anno avrei conosciuto più attaccapanni di quanti pensassi.
Avevo in mente quello che il signor Slowacki mi aveva raccontato della guerra.
Diceva che la guerra è il luogo in cui si confondono la polvere da sparo e il lievito. L'epoca in cui le carceri diventano granai e i granai diventano carceri.
Una volta stavamo aspettando della polvere da sparo e ricevemmo venti sacchi. Quando aprimmo i sacchi ed iniziammo a caricare i cannoni, ci rendemmo conto che si trattava di lievito, che ci avevano mandato un carico sbagliato. E arrivammo alla conclusione che la nostra polvere da sparo probabilmente era finita in qualche panificio industriale.
In quel momento entrò il capo ad appendere la sua lunga giacca. Slowacki smise di parlare della guerra e apri il libro della contabilità, iniziando a scorrere con il dito indice la lunga lista di numeri.
Il giorno in cui venimmo a sapere che la Germania aveva invaso la Polonia, fu come sentire un attaccapanni appuntito infilarsi in mezzo al cuore. Un attaccapanni sul quale la Germania avrebbe appeso il suo cappello e l'impermeabile nero.
Quando tornai a casa trovai mia madre in lacrime, vicino alla finestra, con una lettera in mano. Non c'era bisogno di essere un indovino per sapere cosa dicesse quella lettera.
Oh, figliolo, figlio mio!
Ovviamente la lettera non diceva questo.
Il giorno in cui smisi di lavorare perché pareva che la patria avesse bisogno di me, il direttore mi diede una busta piena di soldi.
La Polonia ha bisogno di te. Buona fortuna, figliolo. Così mi disse.
Anche gli attaccapanni hanno un cuore, pensai. Ma non l'avrei pensato se avessi saputo prima la reazione di mia madre all'aprire quella busta.
Qui ci sono i soldi per la bara, giusti giusti! Oh figliolo, figlio mio!
Anche il signor Slowacki mi disse qualcosa: se non fossi così vecchio...
Solo questo, nient'altro. Se non fossi così vecchio. Poi portò la mano all'angolo dell'occhio, con la speranza di bagnare nel calamaio delle lacrime la punta del dito annerita da tanti conti fatti con la penna. Non ci riuscì e si rattristò ancora di più perché gli occhi non rispondevano al livello di tristezza interiore. Rimase a guardare la punta del dito asciutta, a lungo, con l'espressione del pescatore a cui si è conficcato un amo nell'indice. Più che dolore, vergogna.
Jozef non disse niente. Dalla sera prima era scomparso da casa.
La madre di Jozef era stata abbastanza furba e, prima che i soldati andassero a cercare il ragazzo, era scesa di primo mattino fino al comune per denunciare che suo figlio mancava da casa da qualche giorno e che non sapeva dove si trovasse.
Il segretario comunale borbottò, problemi, sempre problemi, e passò la comunicazione al sergente responsabile dell'arruolamento dei soldati.
Lai sa benissimo dove si trova suo figlio!
Vi ho già detto che non lo so! A casa siamo tutti preoccupati.
Jozef non era l'unico giovane in età da guerra a mancare da casa, e nemmeno uno dei pochi.
Il segretario si impietosì ed offrì una sedia alla donna.
La diserzione è gravemente punita, signora. Lo sapeva?
Trovarono Jozef a pochi chilometri dal paese, nascosto tra i bidoni di latte su un carro trainato dai cavalli.
Se si fosse nascosto in un carro di letame non l'avrebbero trovato così facilmente, disse mia madre.
Proprio così mi sento io, nel letame fino al collo. E comunque mi hanno preso lo stesso.
E mia madre scoppiò di nuovo a piangere.
Non volevo salutare Alma, ma fu lei a insistere per venire alla stazione.
Presto saremo di nuovo assieme, tesoro.
Sì, dissi io non molto convinto.
Mi regalò un bastoncino di cannella.
Da mettere sul cappello.
O dietro l'orecchio, come fanno i falegnami con la matita, vediamo?
Ecco, dietro l'orecchio.
Notai un nodo in gola. Il treno iniziò a fischiare. Alma seguì il treno, con un ombrello bianco - questo è falso, non aveva nessun ombrello bianco, ma sarebbe stato bello se così fosse stato - allungando il collo verso i vagoni, la testa girata a destra, finché il binario non divenne un precipizio.
Ti scriverò tutti i giorni!
Voi siete la retroguardia, state tranquilli! Con queste parole ci fecero coraggio il primo giorno. Ma quella che era la retroguardia, nel giro di poche settimane divenne la prima linea. I nostri generali non erano abili giocatori di scacchi. Comunque ebbi fortuna: fui colpito da una terribile polmonite. E appena guarito scappai dall'ospedale. Durante i giorni della mia fuga, io e Alma riuscimmo a scriverci molte lettere. Prigioniero del desiderio, mi vidi costretto in più di un'occasione ad avvicinare al naso le dita bagnate del mio sperma, così come avevo visto fare ad Alma quel giorno, nella speranza che quello schioccare silenzioso risvegliasse in me il ricordo di lei. Trascorse un anno prima che ci rivedessimo.
Devo dirti una cosa: ho conosciuto un altro.
Un tedesco. Se vuoi possiamo fare una passeggiata. Una passeggiata. Cosa può valere una passeggiata paragonata ad un tedesco? Mettiamoli a confronto, mettiamoli sul piatto della bilancia: un tedesco, una passeggiata. È possibile che la bilancia si muova? Che opponga resistenza? Oscilla forse il suo ago? Nemmeno per sogno! Il tedesco ha facilmente la meglio: il piatto del tedesco scende rapidamente, come fosse di piombo, mentre si alza e inesorabilmente perde quello della passeggiata; la passeggiata vola verso l'alto ma comunque perde, una specie di giustizia poetica. Una maledetta giustizia che non serve a nulla, inventata dal braccio rachitico dell'intellettuale per compensare il risentimento nei confronti del muscoloso braccio tatuato del marinaio che gli ha portato via la ragazza. Giustizia poetica, così la chiamano.
Un passeggiata era troppo poco: le chiesi un fine settimana. Paragonato ad un tedesco anche un fine settimana era comunque cosa da poco. Ma per lo meno era qualcosa di più di una passeggiata.
La guerra non è ancora finita... Dove possiamo andare? Non possiamo allontanarci da Varsavia.
Scelsi io il posto. Saremo andati in un luogo nascosto e distrutto dalla guerra. "In fondo al mio cuore", avrei potuto dire, ma non volevo essere patetico.
Stai tranquilla, non ci vedrà nessuno.
La portai in bicicletta vicino ad una vecchia cava che i tedeschi avevano abbandonato perché di poco interesse. A qualcosa dovrà pur servire il conoscere i percorsi delle lumache, le dissi. Ma lei non mi rispose. Non sorrise nemmeno. Sapendo che la speranza dell'amore inizia con la complicità, non volle ricambiarla. Forse non si ricordava nemmeno delle lumache, o non voleva ricordarsene.
Tuttavia, dopo aver fatto l'amore, mi disse che mi amava. Così come mi disse che sarebbe stata l'ultima volta. Ma non fu l'ultima volta. Poco dopo la passione si riaccese e ci amammo di nuovo.
Devo tornare a Varsavia.
Cosa hai detto a lui?
Ad Hans?
Maledizione: Hans! Proprio Hans doveva chiamarsi il bellimbusto? D'ora in poi dovrò odiare tutti quelli che si chiamano Hans, che si tratti di un tedesco ladro di fidanzate o di un geniale compositore per quartetto d'archi? Avrei dovuto finire per odiare tanto il cameriere di una caffetteria come un onesto imbianchino solo per il fatto di chiamarsi Hans?
Gli ho detto che dovevo andare a trovare una zia ammalata.
Le zie ammalate! Loro valgono più di una passeggiata o di un fine settimana! Non solo, le zie ammalate valgono addirittura più di un tedesco. Oggi inauguriamo il monumento alla Zia Sconosciuta e sono proprio io a dover togliere il telo che lo ricopre, pensai, come un vero scrittore, sempre più vero.
Era giunta l'ora di riprendere la bicicletta e tornare in città. Quando fummo in prossimità di un ponte distrutto, la feci scendere dalla bicicletta. Poi la presi e la buttai nel fiume. La bicicletta, ovviamente.
Ma... Cosa stai facendo?
Non siamo lontani, andremo a piedi, seguiremo i binari. Non hai mai giocato, da piccola, a camminare sulle rotaie?
No.
Per lo meno ricorderai quando sei venuta a salutarmi alla stazione, il giorno che sono partito per il fronte, con un ombrello bianco...
Che ombrello bianco?
È solo un modo di dire, tesoro.
Volevo guadagnare tempo. Assaporare lentamente ognuno dei minuti che mi rimanevano da trascorrere con lei. Ogni ultimo minuto. Buttare la bicicletta nel fiume era un modo per avvicinare a me la scala dell'universo. Volevo rallentare il tempo, tenerlo in mano.
Alma aveva con sé una borsa che non aveva mai aperto durante tutto il fine settimana. Pensai che ciò che conteneva potevano essere gli abiti che avrebbe indossato una volta tornata a Varsavia, vestiti candidi e puliti, senza tracce di bava di lumache. Se è furba come credo, in quella borsa avrà anche il regalo ricevuto dall'ipotetica zia, da mostrare con innocenza al suo tedesco al ritorno.
Guarda, Hans caro, guarda cosa ci ha regalato la zia per la nostra casa! Una cofanetto di ceramica decorata con fiori colorati!
Cos'hai in quella borsa? le chiesi.
Non mi rispose.
Anche il silenzio è una risposta, pensai.
Il silenzio non è una risposta, le dissi.
Neanche una parola. E in silenzio ci incamminammo, uno di fianco all'altro, lungo i binari morti. Dopo poco allungai il passo, sperando che mi raggiungesse. Ma non lo fece, continuò a seguirmi rimanendo un po' indietro. Quel gesto mi ferì: l'avrei voluta al mio fianco, come quando passeggiavamo sulla riva del fiume, per l'ultima volta.
Avremmo dovuto sapere che in tempo di guerra i treni viaggiano quando vogliono e come vogliono, ma non lo sapevamo. In realtà eravamo come bambini ingenui, lei a causa del suo imminente matrimonio con il tedesco Hans, io perché stavo assaporando il gusto del dopoguerra.
Riassumendo: non ancora apertasi l'alba, ma noi, invece, lacerati dentro, continuammo a camminare lungo i binari. Io davanti, lei dietro. Non voleva mettersi al mio fianco. Non abboccherà più un'altra volta, pensai.
Era il giorno del nostro addio, e lo sapevamo.
Quando udimmo il fischio del treno, riuscimmo appena in tempo a spostarci dalle rotaie. Con un gesto automatico, lo stesso della via della cannella, girai la testa a sinistra per guardare indietro, alla ricerca di Alma.
Lei invece, quando avvertì il treno alle sue spalle, la girò verso destra. Il fatto è che aveva sempre fatto così dal giorno in cui ci eravamo conosciuti: quando camminava in senso contrario e, timidamente come il primo giorno, guardava la vetrina dei cappelli; quando, alla ricerca dei baci del pomeriggio, iniziammo a passeggiare sulle rive della Vistola oppure, l'ultima volta, quando mi aveva salutato alla partenza del treno che mi avrebbe portato al fronte; lei girava sempre la testa a destra.
Quel gesto salvò la mia vita e condannò la sua.
Anche oggi, in questo esilio parigino, quando passeggio sulle rive della Senna - le acque del fiume sono consolatorie per l'esiliato, perché il loro tranquillizzante movimento non può mai diventare l'esilio, come invece lo è la terra che calpesti e uno sconosciuto mi fa un gesto di saluto e io giro la testa a sinistra, sento un sibilo profondo sfiorarmi l'orecchio sinistro, come la lama di un coltello.
È lei, penso, si tratta di un messaggio. E perdono a me stesso la stupidità: perché la stupidità, l'ingenuità e l'inesperienza sono cose umane e, in quanto umane, perdonabili.
La borsa che Alma portava con sé rovesciò il suo contenuto vicino ai binari: erano le lettere che le avevo mandato dal fronte. Non ho mai capito perché le avesse portate con sé, cosa avesse intenzione di farne.
Il macchinista del treno non si rese nemmeno conto di aver investito e scaraventato a terra una donna che adesso giaceva vicino ai binari con il viso insanguinato. E questo nel caso in cui sul treno ci fosse stato un macchinista, perché così come c'è gente senza anima, allo stesso modo esistono treni senza macchinista. Treni che da tempo hanno venduto al diavolo il macchinista che portavano dentro.
Il tempo era umido, presto le lumache sarebbe uscite dai loro buchi, con le loro spirali sulla schiena: troppo tardi, come quasi tutte le idee brillanti, le riflessioni pertinenti, le strategie efficaci e i buoni sentimenti; ormai non rimaneva che dare testimonianza delle rovine del paese e delle travi bruciate.
Non ebbi il coraggio di abbracciare il suo corpo senza vita.
Una strada, una vita o forse di più, come un bastoncino di cannella spezzato.
Inginocchiato a terra, al bordo delle rotaie raccolsi con rabbia dei rametti sporchi di fango; bastoncini secchi il più possibile simili a quelli di cannella, e li sminuzzai tra le dita per poi portarli alla bocca, in modo che il fango e i bastoncini soffocassero nello stomaco il mio grido.
Volevo forse inghiottire il mondo in modo che sparisse dalla mia vista? Chi lo sa! La grammatica e la narrativa non sono mai state in grado di esprimere la disperazione.
Non so per quanto tempo camminai smarrito, vagando nel bosco, pregando ad urli che i franchi tiratori che percepivo ma non vedevo mi sparassero. Non ebbi fortuna. O forse ebbi molta fortuna. Prima di arrivare in città, al piano terra di un edificio ferroviario distrutto dalle bombe, vidi un attaccapanni ancora in piedi, intatto, su cui erano appesi un soprabito e un cappello. Quell'immagine mi scosse: tra le pareti crollate, il soprabito rimaneva al suo posto, come se il capostazione stesse per arrivare da un momento all'altro.
Quando mi avviai verso la piccola stazione, un cane mi si avvicinò abbaiando, con ragione o senza ragione.
Un abbaiare in quattro tempi: è-la-gue-rra! è-la-gue-rra!
Il cane scuoteva la testa, agitato, da un parte e dall'altra, nei due sensi con la stessa passione animale. O con la stessa mancanza di passione animale, dovrei dire. Quella bestia abbaiava semplicemente per un riflesso muscolare tipico di chi non sa nulla delle strade alla cannella, delle vetrine di cappelli e degli ombrelli bianchi.
È-la-gue-rra! È-la-gue-rra!
Lo so, imbecille, lo so! Taci!
Presi una sasso dalle rotaie e gliela lanciai, sfiorandolo; come se avesse capito qualcosa, smise di abbaiare. A causa della pietra o forse per i miei singhiozzi di pianto, non lo so.
Guardai di nuovo l'attaccapanni: prima notai il cordino rosso del cappello, poi il soprabito blu con i galloni e il fischietto argentato che pendeva da una delle tasche.
Pensai che il mondo è degli oggetti, appartiene agli oggetti smarriti e abbandonati e non, come mi aveva portato a credere fino a quel momento la mia formazione pseudo-umanistica, il luogo dove convivono uomini e donne.
Il cane ricominciò di nuovo ad abbaiare. Sentivo la testa che mi stava scoppiando.
Mi asciugai le lacrime con la manica del soprabito appeso all'attaccapanni. I latrati del cane erano sempre più acuti. Presi il fischietto del capostazione e soffiai con forza.
Ne uscì un fischio stonato. Non era venuta nessuna ragazza a girare i fogli bianchi tra le pareti crollate della stazione.
All'improvviso il cane smise di abbaiare.
Ricominciai a camminare lungo i binari e lui mi seguì, mansueto e obbediente, e da quell'istante non si allontanò più, come se un vincolo che io non allora non capivo ma che per lui era chiaro lo legasse a me.
Non saprei dire per quante ore continuai a camminare. Arrivai alla frontiera con le scarpe piene di fango e le calze inzuppate. Benché il cartello della frontiera fosse ancora lì, non c'era nessuno; era difficile capire se quella fosse o no la frontiera di qualcosa. A chi si poteva chiedere?
Io e il cane ci guardammo, senza sapere dove andare. Il sacco di pelle che copriva le sue ossa era marrone chiaro.
Continueremo verso ovest, Cannella.
Dopo tutto, pensai, anche lui si meritava di avere un nome.
Mentre continuavamo a camminare, lungo la via principale di un paese fantasma distrutto dai bombardamenti, iniziai a raccontare al cane della via della cannella.
Quella strada profumava di cannella: Non di cannella in polvere, ma di cannella in bastoncini. È diverso, lo sapevi? Molto diverso.
Non direi che il cane non stesse bene con me. Non posso dire che non prestasse attenzione, grazie anche al suo nuovo nome, al panettiere, al venditore di cappelli e a chiunque transitasse su quella strada, a quei fantasmi che ricreavo con le mie parole. Come potevo interpretare altrimenti quell'esplosione in salti spontanei e quell'abbaiare composto? Io allungavo la mano, stringevo le maniglie di porte e finestre mezze scardinate, abbracciavo tra le macerie le persiane come se si trattasse di esseri vivi, salutavo le porte squarciate, baciavo la mano a colonne ridotte a pezzi. Mi rivolgevo con cortesia a calcinacci e travi spezzate. Fu un peccato non aver preso il cappello del capostazione per potermelo togliere come è dovuto davanti a gente che se lo merita! Come va, signor Minkiewicz? Chiesi al riflesso della mia immagine invecchiata su un vetro incrinato, oggi è davvero una bella giornata per i suoi dolori reumatici, vero? Dammi il Kurier, ragazzo... Tutto bene a casa, Kotkowski? E così anche il figlio più piccolo si è sposato, non si lamenti, per lo meno non mancherà mai il pane a casa sua! Oppure, più affettuosamente e senza tanto entusiasmo, appoggiando la mano su una maniglia rotonda dorata: Sembra che Minkiewicz confezioni i suoi cappelli con filo di cannella, non le pare?
Mi sentivo ottimista, spinto da una incomprensibile energia. Quando il freddo e la paura ti fanno tremare, solo gridare può salvarti: obbligare a colpi di pugnale questo dio sprecone, ridicolo e pigro, che vive dentro di te ad abbandonare la tua casa. Affacciati alla finestra, sfida i franchi tiratori, ridi di loro e che loro ridano di te a crepapelle! Non abbiamo bisogno di predicatori, ma di buffoni! Buffoni!
E mentre urlavo a tutti queste parole, tenevo la testa alta e lo sguardo dritto anche se, senza perdere la buona educazione, mi rivolgevo alla gente con un movimento del collo. Mi inchinavo con la rispettosa flessione a quarantacinque gradi che richiedendo gli usi e i costumi del mio paese, con la generosa disposizione di chi è pronto ad aiutare il prossimo.
Anche dopo aver salutato quel paese fantasma, dove avevo augurato a tutti buona fortuna e le migliori cose, il cane era ancora al mio fianco, la lingua fuori e gli occhi lucidi, come se conoscesse la storia dello scudiero a cui il suo padrone avrebbe regalato un'isola in cambio dell'aiuto datogli nella battaglia contro mulini immaginari.
Ma io, cosa posso regalarti?
Dovevo andarmene al più presto da quella terra di follia. Cominciai a correre, sentivo sotto i piedi uno scricchiolare fastidioso, come se stessi triturando con i denti dei gusci di lumache; sentivo il crepitare del bosco non in bocca ma come un brivido sotto i piedi. Cos'è l'impotenza se non quell'impressione di avere labbra cucite al posto dei talloni? Il bisogno di gridare anche con i piedi per scaricare la rabbia e non poterlo fare, sentire che manca il respiro.
I primi fiocchi sembravano voler opporre resistenza, ma il cielo annunciava neve e questo era sufficiente perché quel giorno i cacciabombardieri non si alzassero in volo.
Continuai a correre, sapendo che non sarebbero stati sufficienti mille anni per cancellare quel patetico valzer privo di grazia che la mia disperazione stava tracciando, inciampando in gole silvestri che non erano altro che rami spezzati, con il collo teso, senza guardare indietro.
© Harkaitz Cano
© Traduzione: Roberta Gozzi